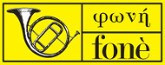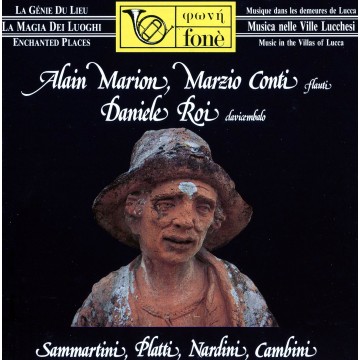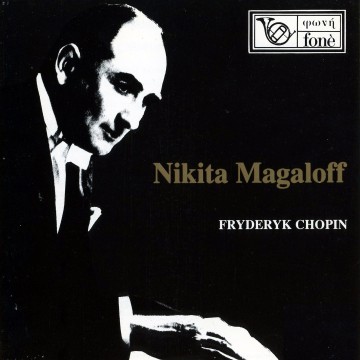- Nuovo
Tra Mistico e Occulto - F. Busoni - G. Mariotti (High Resolution Audio)
[Hi-Res Audio] Tra Mistico e Occulto - F. Busoni
Giuseppe Mariotti piano
TRA MISTICO E OCCULTO
1 Sonatina seconda Kind. 259 (1912)
2 Sonatina in diem nativitatis Christi MCMXVII Kind. 274 (1917)
3 Toccata. Preludio - Fantasia - Ciaccona Kind. 287 (1920) Quasi Presto, arditamente - Sostenuto, quasi Adagio - Allegro risoluto
4 Berceuse (Andantino calmo) Kind. 252 (1909)
5 Fantasia contrappuntistica Kind. 256 (1910)
L’Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Abbozzo di una nuova estetica della musica) del 1906, il rivoluzionario scritto di Busoni che tanto scompiglio portò nell’ambiente musicale europeo di quegli anni, reca nella dedica il nome del poeta Rainer Maria Rilke, ”musico della parola”, dalle cui opere il compositore aveva attinto il titolo e il carattere delle Elegie. Il romanticismo aveva già dato il segnale del ritorno ad antiche idee mistiche, e con il cambio del secolo, periodo gravido d'espressioni decadenti e premonizioni tragiche, il misticismo trovò fautori entusiasti come M. Maeterling, P. Claudel e, nell’area tedesca, appunto R. M. Rilke. Scrisse Sartre: «...l’Occidente stava soffocando... Dato che non aveva nemici visibili, la borghesia cominciò a pascersi della paura della propria ombra... si parlava di spiritualismo e di ectoplasmi, l’Aldilà sembrava tanto vicino... ». Le discipline dell’arcano iniziarono in quegli anni a esercitare su Busoni una notevole ascendenza. Frequentò sedute medianiche e iniziò a interessarsi d'occultismo, spiritismo e chiaroveggenza. Formulò teorie sulla facoltà di vedere fantasmi: l’uomo possederebbe la capacità di vedere - per brevissimi istanti - nel futuro o nel passato. «...Non sarebbe altro che uno sguardo momentaneo e malsicuro gettato - nel presente o nel passato. Tutto procede in forma di cerchio e così dev’essere per la chiaroveggenza. È un fenomeno analogo a quel che si produce in una stazione radiotelegrafica, la quale trasmette fino alla stessa distanza in tutte le direzioni... ». In modo analogo spiegò le sue convinzioni in materia di percezioni extrasensoriali: possiamo quindi ragionevolmente dedurre che Busoni credette nell’esistenza di enti e forze non razionalmente o empiricamente spiegabili che tuttavia sarebbe possibile conoscere e forse dominare, nel suo caso anche attraverso l’esperienza musicale. Durante le tournée americane Busoni entrò in contatto con le dottrine teosofiche sviluppate negli Stati Uniti alla fine del secolo. Esse propugnavano una via d'evoluzione etica e spirituale che, attraverso la purificazione progressiva dei motivi e delle opere, giunge a realizzare un ideale di perfezione mistica ricco di tutti gli attributi della sapienza, della serenità, della bellezza e della potenza: si possono facilmente rintracciare i fondamenti estetici della ”Nuova classicità” (Junge Klassizität), in altre parole il ritorno a schemi compositivi semplici, chiari e belli che trovano piena espressione nella Sonatina in diem nativitatis Christi MCMXVII. Nel maggio del 1912 Busoni acquistò a Berlino il grande quadro del futurista Umberto Boccioni ”La città che sale”. Al maggio-luglio dello stesso anno risale la composizione della Sonatina seconda, il suo brano più avanguardistico che contiene in sé una quantità d'elementi mistici ed occulti. Come si legge nel suo diario berlinese «la notte il Boccioni nella stanza da musica, illuminato dalla magica luce che penetra dalla piazza sottostante, assume una strana, magica sembianza ». Non è difficile immaginare il compositore seduto nella stanza in penombra, circondato da statue di Buddha, libri rari e dalla ”Città che sale” proiettante i suoi riflessi multicolori. Come l’occulto prescinde dalle distinzioni spaziali e temporali, attraverso le quali l’individuo si orienta nel mondo reale, così Busoni annulla spesso le linee di battuta, i segni d'alterazione e, specialmente, la tonalità: si realizza la manifestazione in termini musicali di ciò che si svolge nelle zone oscure della sua personalità. Questa sensibilità all’occultismo e al misticismo arricchì enormemente il linguaggio di Busoni attraverso la creazione di nuovi concetti e mezzi d’espressione e ne fu fermento essenziale dell’ultima fase creativa, il cui culmine massimo è raggiunto, nella produzione per pianoforte, dalla Fantasia Contrappuntistica. Qui sono racchiusi tutti gli elementi caratterizzanti del pensiero estetico busoniano. La geniale unione del linguaggio musicale moderno al contrappunto dell’Arte della Fuga di J. S. Bach genera una sorta di “esperienza” mistica attraverso cui i moti interni dell’anima acquistano il predominio sul pensiero razionale, sulla volontà e sulla coscienza. In un complesso d'ardite armonie e pura polifonia il cammino procede elevandosi tra momenti di esaltazione e di mistero, slanci visionari o episodi pensosi, profonde meditazioni e vaghi riflessi. Quando la musica risuona l’essere umano è capace di acquistare una capacità trascendentale che lo porta ad un nuovo piano di consapevolezza, dove il mondo temporale è sommerso dall’universo risuonante. L’opera d’arte musicale esiste prima e dopo che ha terminato di risuonare, è contemporaneamente dentro e fuori del tempo. È questa ”Onnipresenza del Tempo”, presente anche nella Berceuse, che sintetizza l’ideale d'estasi mistica idealizzata da Busoni: «...noi uomini concepiamo il tempo come una linea che parte da un punto dietro a noi e procede in avanti, mentre esso deve espandersi in tutte le direzioni, come tutto nel sistema cosmico... ». Unicamente con la quiete dello spirito possiamo tuttavia penetrare i più profondi misteri ed aspirare a una vita più alta e più piena, che è propria alla coscienza umana. «Solo chi guarda innanzi ha lo sguardo lieto», dice Faust. Il significato esoterico di questi principi venne espresso appunto per l’ultima volta nell’incompiuta opera Dr. Faust, dei cui temi e forti tinte è impregnata la Toccata. L’alta e vissuta spiritualità del compositore lo rese ben cosciente d’imboccare una nuova strada, piena di conseguenze per la musica del XX° secolo. «Ancora inesausti sono i simboli/ che il genio onnipotente in sé comprende;/ l’opera produrrà una scuola/ che per decenni maturerà feconda./ Che ognuno ne tragga il proprio insegnamento/ in modo che Spirito s'aggiunga ad altro Spirito:/ questo è il senso della continua ascesa/ la danza chiuderà poi il suo cerchio».
Giuseppe Mariotti